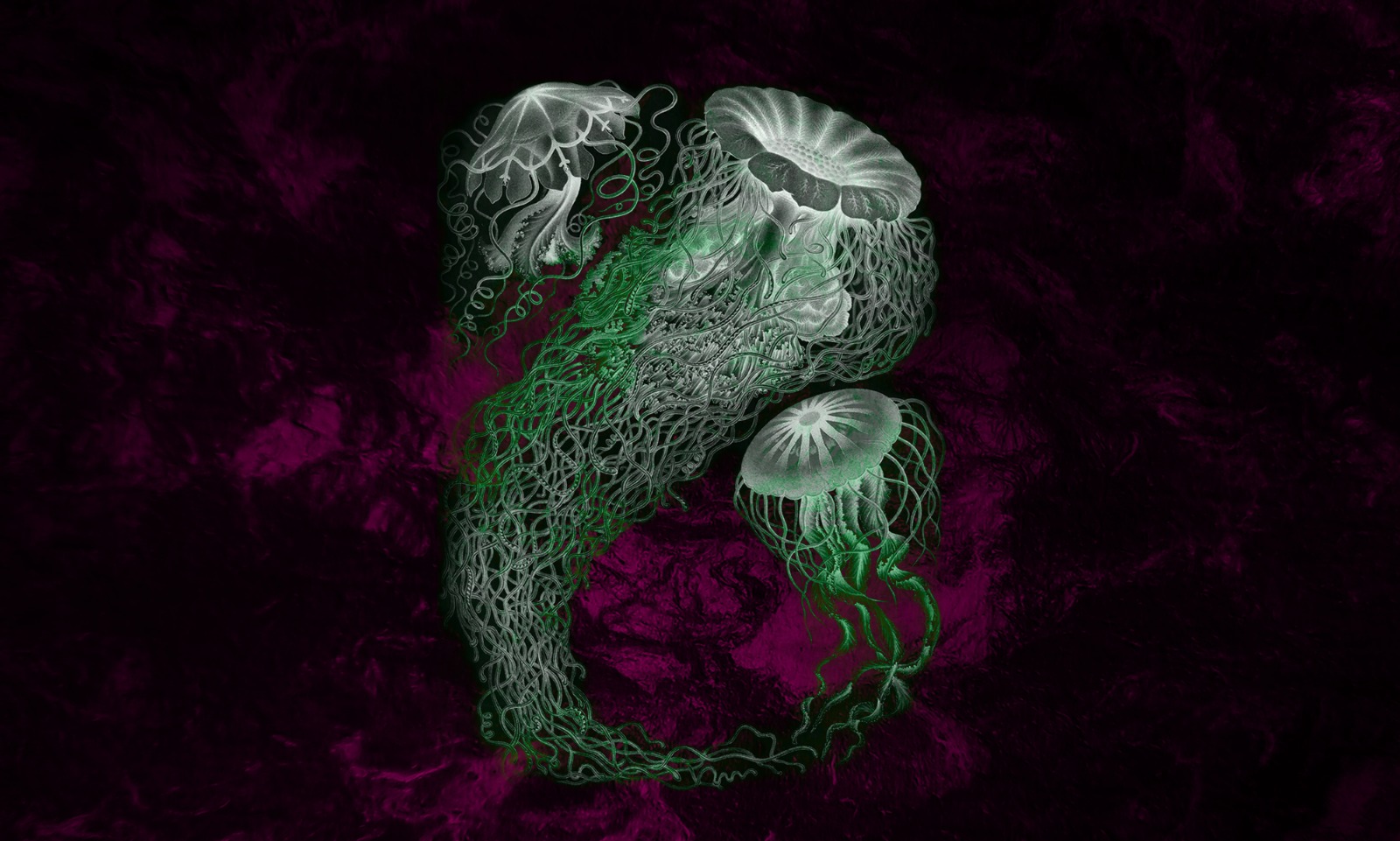foto dal web
Premessa
Ero in Nicaragua nell’autunno del 1990 in missione in qualità di esperto in salute mentale, per conto della Cooperazione Italiana Governativa. Nel febbraio dello stesso anno i sandinisti avevano perso le elezioni e si era costituito un Governo di Unità Nazionale guidato da Violeta Chamorro, ben visto dagli Stati Uniti. Si respirava, però un’aria triste. A causa della sconfitta, inattesa, molti componenti del Fronte Nazionale di Liberazione “Augusto Sandino” erano depressi, fuori da ogni gestione degli apparati amministrativi. Nello stesso tempo infuriava ancora la guerra civile nel vicino Savador, che si stava acuendo dopo il fallimento dell’offensiva del 1989 realizzata dal Fronte Liberazione Nazionale “Farabundo Martì”. Nel novembre del 1989 c’era stato l’assassinio di sei frati gesuiti, tra cui Martin Barò, docente di Psicologia presso l’Università Centroamericana (UCA), ad opera di un plotone delle Forze Armate Governative: un episodio che scosse la comunità internazionale, la quale chiese la fine della guerra, conclusasi poi nel 1992.
Durante la mia permanenza in Nicaragua ho conosciuto Sergio, ex guerrigliero salvadoregno, che mi ha parlato della crudeltà della guerra e delle conseguenze catastrofiche sulla sua salute mentale. Incubi notturni, crisi d’ansia in pieno giorno, paura di essere assalito da sconosciuti, ipervigilanza senza un motivo, difficoltà a fidarsi anche degli amici, scarsa autostima. Stava talmente male durante la guerra in Salvador che gli stessi suoi compagni gli hanno detto di lasciare il Fronte di Liberazione. E’ andato, così, a Cuba, dove ha frequentato un corso di film-maker nella Scuola di Cinematografia fondata da Gabriel Garcìa Marquez.
“Quel corso mi ha salvato” mi diceva. “Ho vissuto in un clima accogliente, che mi incoraggiava. Ho cominciato a stimarmi un po’ di più e anche i disturbi si sono ridotti. Stavo nettamente meglio senza farmaci e senza interventi psicologici”.
Ho cominciato a pensare che il trattamento del cosiddetto “disturbo post-traumatico da stress” non potesse limitarsi ad un intervento tecnico, ma potesse trarre giovamento dal ruolo positivo della comunità.
E in realtà Martin Barò, in questo suo scritto, a proposito del trauma psicosociale, afferma che “appare del tutto evidente la insufficienza della psicoterapia, individuale o di gruppo, intesa come un processo di intervento strettamente psicologico. Naturalmente non si tratta di abbandonare al loro destino quelle persone che vivono sulla propria pelle la distruzione alienante della guerra. Ciò che si afferma è che questo sforzo è insufficiente. Se non si produrrà un cambiamento significativo nelle relazioni sociali (strutturali, gruppali e interpersonali), come oggi si realizzano nel Paese, il trattamento del singolo individuo sarà quanto mai incompleto”.
Rocco Canosa
Firenze, febbraio 2025
IL TRAUMA PSICOSOCIALE
1. Caratteristiche del trauma psicosociale in situazione di guerra
Etimologicamente “trauma” significa “ferita”.
In psicologia, si è soliti parlare di “trauma” per riferirsi ad una esperienza che colpisce la persona in tal modo da lasciarla con un marchio, cioè, provoca in questa una conseguenza permanente.
Se si utilizza il termine “trauma” è perché si intende che questa conseguenza è sfavorevole, che si tratta, ovvero, di una impronta negativa per la vita di una persona.
In generale, si definisce “trauma psichico” la ferita particolare che un’esperienza difficile o eccezionale ̶ la morte di un caro, una situazione di grande tensione o sofferenza, un fatto dolorosamente frustrante ̶ rimane in un individuo. Per esempio, un bambino che vede morire i genitori in un incidente o in un incendio. A volte, in senso analogo, si utilizza il termine “trauma sociale” rispetto un processo storico che può aver colpito una intera popolazione. E’ il caso, per esempio, del popolo tedesco e del popolo ebraico dopo l’esperienza della ‘soluzione finale’.
Qui si utilizza il termine “trauma psicosociale” per porre l’accento sul carattere dialettico della ferita causata dalla guerra che si prolunga nel tempo come quella dell’El Salvador.
Con questo non si vuol dire che si produca un effetto uniforme o comune in tutta la popolazione o che la esperienza della guerra possa avere un impatto automatico sulla singola persona; più precisamente se si parla della caratteristica dialettica del trauma psicosociale è per sottolineare che la ferita dipenderà dalle particolari condizioni di vita di ciascun individuo, in relazione alla sua estrazione sociale, al suo grado di partecipazione al conflitto, così come alle altre caratteristiche della sua personalità e delle sue esperienze di vita.
La sofferenza arrecata dalla guerra offre anche per alcune persone la opportunità di crescere umanamente. L’impegno pubblico di alcuni, come quello dimostrato dall’Arcivescovo martire di San Salvador Mons. Oscar Arnulfo Romero, mostra paradigmaticamente la crescita di una persona a mano a mano che si intensificavano le persecuzioni e gli attacchi contro di lui. Mons. Romero è l’espressione migliore di come molti altri salvadoregni, durante la guerra, abbiano sviluppato eccezionali virtù umane di limpido altruismo e solidarietà.
Parlando di trauma psicosociale, però, si vogliono sottolineare anche due aspetti che frequentemente si tendono a dimenticare:
a) che la ferita riportata dalla persona è stata prodotta socialmente, ovvero che le sue radici non si trovano nell’individuo, ma nella società;
b) che la sua stessa natura si alimenta e si mantiene nella relazione tra l’individuo e la società, attraverso le diverse mediazioni istituzionali, gruppali e anche individuali.
Questo comporta ovvie e importanti conseguenze nel momento in cui bisogna decidere cosa fare per superare questi traumi.
- Il trauma psicosociale come disumanizzazione
Joaquìn Samayoa (psicologo, in un lavoro del 1987) sostiene che i cambiamenti sul piano conoscitivo e comportamentale che si verificano a causa della guerra , provocano un processo di disumanizzazione, inteso come impoverimento di quattro importanti capacità dell’essere umano:
a) capacità di pensare lucidamente
b) capacità di confrontarsi con la realtà
c) sensibilità di fronte alla sofferenza altrui
d) sentimento di speranza
Quali sono questi cambiamenti conoscitivi e comportamentali necessari per adattarsi alla guerra e che sono alla base della disumanizzazione delle persone?
Samayoa ne cita cinque:
1. la disattenzione selettiva e l’aggrapparsi ai pregiudizi
2. l’assolutizzazione, l’idealizzazione e la rigidità ideologica
3. lo scetticismo evasivo
4. la difesa paranoide
5. l’odio e il desiderio di vendetta.
Per analizzare come emergano e vadano a configurarsi questi schemi conoscitivi e comportamentali, Samayoa segnala tre meccanismi adattivi o di “sopravvivenza” :
a) l’insicurezza di fronte al proprio destino
b) la carenza di obiettivi, anche nel senso di ciò che si deve fare
c) la necessità di vincolarsi o appartenere a qualche gruppo
Una linea differente di pensiero è stata sviluppata, attraverso la propria esperienza psicoterapeutica, in Cile dal gruppo facente capo a Elisabeth Lira (1985 ̶ 1986). Secondo questo gruppo una situazione di terrorismo di stato come quello che si vive nel Cile di Pinochet provoca nelle persone uno stato di paura e, benché la paura sia un vissuto soggettivo e in un certo senso privata, “il suo prodursi simultaneamente in migliaia di persone in una società assume una rilevanza insospettata nella condotta sociale e politica”.
Secondo questi psicologi, quattro sono le caratteristiche psicologiche principali dei processi che si scatenano a causa della paura:
1) la sensazione di vulnerabilità
2) uno stato esacerbato di allerta (iperarousal)
3) un sentimento di impotenza o perdita di controllo sulla propria vita
4) un’alterazione del senso di realtà, nell’impossibilità di validare oggettivamente le proprie esperienze e conoscenze.
Le argomentazioni di Samayoa e del gruppo cileno sono complementari: in un caso si sottolineano gli aspetti conoscitivi e comportamentali, nell’altro si pone l’accento sulla mediazione di un elemento affettivo, la paura. Ritroviamo, così, i tre aspetti classici dell’analisi psicologica: la conoscenza, l’affettività e il comportamento (che alcuni sostituiscono con la volontà).
Conviene, tuttavia, segnalare i limiti di ambedue i modelli. Nel caso dei cileni è chiaro che le loro analisi si focalizzano su quei settori della popolazione che hanno costituito l’obiettivo della repressione di Pinochet; rimarrebbero esclusi, pertanto, i settori della popolazione favorevoli a Pinochet, coloro i quali più che la paura hanno sperimentato frequentemente soddisfazione e sicurezza fondate su una politica che garantiva il loro dominio di classe.
Le osservazioni di Samayoa sono più ampie e, in linea di principio, possono applicarsi a tutti i settori della popolazione, a tutti coloro che devono adattarsi a le nuove circostanze storiche.
Ma più precisamente è questo ruolo tanto importante attribuito all’adattamento che trovo insoddisfacente nel suo lavoro. Sembrerebbe che i gruppi e le persone siano esterni alla situazione della guerra e a questa siano obbligati ad adattarsi. Si tratterebbe, dunque, di una concezione fondamentalmente adesiva e anche passiva di fronte alla realtà storica. Al contrario, i dati ci fanno affermare il ruolo essenziale e attivo che svolgono i gruppi e gli individui come soggetti della storia, peraltro vissuta in maniera alienata.
Senza dubbio per molti salvadoregni la guerra è qualcosa di imposto; ma per non pochi la guerra è qualcosa che essi stessi contribuiscono a favorire e a sviluppare e, conseguentemente, non si comprende bene la loro partecipazione in questi processi se si guarda da una prospettiva semplicisticamente “adattiva”. Probabilmente, Samayoa non vuole negare questo, però il suo modello ha questo limite o, per lo meno, lascia aperta questa ambiguità. - Cristallizzazione delle relazioni sociali
Dal nostro punto di vista, crediamo che il modo migliore per comprendere il trauma psicosociale che sperimentano oggi gli abitanti di El Salvador sia quello di concepirlo come la cristallizzazione o la materializzazione nelle persone delle relazioni sociali che si vivono nel Paese.
Non si nasconde che sottostà a questa affermazione la visione dell’essere umano come prodotto di una storia peculiare, che in ciascun caso si concretizza in quelle relazioni sociali nelle quali l’individuo è parte attiva o passiva. Ne consegue che il carattere delle principali relazioni sociali prenderà corpo nelle persone. Quale ruolo giochi ciascuno degli elementi psichici ̶ conoscenza, affettività, volontà ̶ bisognerà esaminarlo in ogni situazione, però, in linea di principio, tutte le persone saranno coinvolte, nella loro vita, nelle relazioni di guerra. Di conseguenza ognuno sarà implicato secondo la sua particolare collocazione sociale e la sua concreta maniera di partecipazione nei processi di guerra.
Il trauma psicosociale sperimentato dalle persone rivela, dunque, relazioni sociali alienanti, che negano il carattere umano del “nemico”, che viene rifiutato come interlocutore, poiché si cerca di distruggerlo. La propria personalità è affermata attraverso la disumanizzazione della relazione con l’altro.
Se la guerra di El Salvador è caratterizzata dalla polarizzazione sociale, dalla menzogna istituzionalizzata e dalla militarizzazione della vita sociale, è necessario riflettere su come questi tre aspetti vanno cristallizzandosi nelle persone. Non si tratta di cercare una corrispondenza meccanica che oggettiverebbe gli aspetti analitici di una realtà storica; piuttosto è opportuno vedere come la specificità della guerra salvadoregna stia segnando indelebilmente sia gruppi che singole persone; come, cioè, vada cristallizzandosi nel trauma psicosociale.
Quelle che seguono sono alcune ipotesi che cercano di spiegare i disturbi psichici, ma come tutte le ipotesi di lavoro dovranno essere verificate dalla conoscenza empirica.
In primo luogo crediamo che le diverse forme di somatizzazione costituiscano il radicamento nel corpo della polarizzazione sociale.
Non si afferma che tutto il processo di polarizzazione si radica nell’organismo, né che tutto il disturbo psicosomatico è attribuibile alla condizione di vita caratterizzata dalla polarizzazione bellica; ciò che si dice è che la esperienza acuta della polarizzazione può radicarsi e frequentemente lo fa nel proprio corpo. Si tratta di sottolineare , dunque, che i gruppi e le persone più predisposte a sperimentare questo tipo di disturbo siano quelli che sono colpiti dal disastro della polarizzazione: sono gli abitanti dei luoghi che continuamente passano i controlli da una parte all’altra, che sono sottomessi a un intenso bombardamento ideologico dell’una o dell’altra parte senza poter affermare la propria opinione, compresi quelli che obbligano se stessi ad assumere posizioni estreme e rigide in favore del proprio gruppo.
Allo squilibrio sociale corrisponde uno squilibrio personale e anche somatico, fino a giungere a forme gravi di alienazione psicotica osservate in alcuni giovani delle popolazioni in conflitto.
In secondo luogo, il clima imperante di menzogna permea negativamente l’identità delle persone. In vari modi. Innanzitutto, perché nascondere la realtà genera una scissione schizoide tra i vissuti soggettivi e la vita sociale, che non offre un campo per la formazione valida delle proprie conoscenze o, nel migliore dei casi, lo riferisce ad un circuito sociale estremamente ristretto. A questa difficoltà di formazione valida corrisponde sia il sentimento di insicurezza su ciò che si pensa, sia lo scetticismo di fronte alle diverse opzioni sociali e politiche.
Quando la menzogna deve essere assunta come forma di vita e le persone si vedono costrette a condurre una doppia esistenza ̶ è il caso di tutti coloro i quali lavorano in clandestinità ̶ il problema si aggrava, non tanto perché non si incontra il modo di formalizzare e validare la propria esperienza, quanto perché la necessità di agire su due piani finisce per generare una confusione di morale e di vita. Non pochi finiscono per abbandonare questo stile di vita tanto squilibrato e questo produce subito una svalutazione della propria immagine e un sentimento di colpa di fronte alle proprie convinzioni e di fronte ai vecchi compagni di lotta. Elisabeth Lira e i suoi colleghi hanno analizzato con chiarezza i problemi di identità che derivano dalla impossibilità di organizzare la vita in sintonia con i propri valori politici quando questi valori sono contrari al regime costituito.
Alla fine, la militarizzazione della vita sociale piò produrre una progressiva militarizzazione della mente. Ancora una volta, non si tratta di un effetto semplice, né automatico, ma pare che non ci sia alcun dubbio che la violenza così intensa che si usa nelle relazioni interpersonali, comprese le più intime, così come la distruttività sociopatica utilizzata da alcuni membri o ex membri delle forze militari, si relazionino strettamente con la crescente preponderanza delle forme militari di pensare, sentire e agire nella vita sociale.
L’aspetto più grave di questa militarizzazione psicosociale è quando si trasforma in una forma “normale” di essere, trasmessa dai processi di socializzazione, come accade nei bambini, i quali ingenuamente affermano che per farla finita con la povertà bisogna ammazzare tutti i poveri. - Conclusioni: il compito psicosociale
La guerra infinita è alla base della normalizzazione di questo tipo di relazioni sociali disumanizzate, il cui impatto sulle persone va dal disturbo somatico fino alla destrutturazione psichica, passando per l’indebolimento della personalità che non trova la possibilità di affermare con autenticità la propria identità.
Non si possono capire, dunque, i disturbi somatici senza tener conto della tensione polarizzante i conflitti, come non si può comprendere la inibizione sociopolitica e la passività se non tenendo presente la menzogna istituzionalizzata, né si può capire l’estremismo ideologico se non lo si riferisce alla militarizzazione della vita sociale.
Però, a loro volta, le persone che si vanno formando in questo contesto, tendono ad assumere come naturale il disprezzo della vita umana, la legge del più forte come criterio sociale e la corruzione come stile di vita, aggravando un circolo vizioso che tende a perpetuare la guerra sia oggettiva che soggettiva.
Non è l’obiettivo del presente lavoro esaminare le forme con le quali deve essere affrontato questo problema. Però appare del tutto evidente la insufficienza della psicoterapia, individuale o di gruppo, intesa come un processo di intervento strettamente psicologico. Naturalmente non si tratta di abbandonare al loro destino quelle persone che vivono sulla propria pelle la distruzione alienante della guerra. Ciò che si afferma è che questo sforzo è insufficiente. Se non si produrrà un cambiamento significativo nelle relazioni sociali (strutturali, gruppali e interpersonali), come oggi si realizzano nel Paese, il trattamento del singolo individuo sarà quanto mai incompleto.
In El Salvador è necessario iniziare un intenso lavoro di depolarizzazione, deideologizzazione e demilitarizzazione che renda sane le relazioni sociali e permetta alle persone di elaborare la propria storia in un contesto interpersonale differente da quello attuale. Dico in termini positivi, è necessario lavorare per creare un nuovo quadro di convivenza, un nuovo “contratto sociale”, nell’accezione migliore del termine, che permetta la interazione collettiva, senza la quale il disaccordo si trasforma in reciproca negazione. C’è da lavorare per una “sincerità” sociale che possa far conoscere le realtà prima di definirle, ed accettare i fatti prima di interpretarli.
Bisogna, infine, impegnarsi per educare con la ragione e non con la forza, in modo che la convivenza si fondi sulla reciproca complementarietà per risolvere i problemi e non sulla violenza per imporre la propria alternativa.
IL TRAUMA PSICOSOCIALE
Revista de Psicologia de El Salvador, n. 35, Enero – Marzo 1990, Universidad Centroamericana Josè Simon Canas, Departamento de Psicologia y Educaciòn, San Salvador, El Salvador, C.A,
di Ignacio Martìn ̶̶ Barò*
Traduzione di Rocco M. Canosa**
*Ignacio Martin Barò (n. Valladolid, 1942 – † El Salvador, 1989) è stato un psicologo e sacerdote gesuita spagnolo che ha trascorso gran parte della sua vita alla ricerca della realtà sociale dura e politica di un piccolo paese latinoamericano, il Salvador, dove ha insegnato presso l’Università Centroamericana “José Simeon Cañas” (UCA), del cui Dipartimento di Psicologia e Formazione era responsabile.
Ha combattuto per i diritti umani, l’uguaglianza e la giustizia sociale in El Salvador, criticando l’impatto negativo della politica degli Stati Uniti per il suo paese. Era influente su una vasta gamma di accademici e attivisti degli Stati Uniti. Era un seguace di teologia della liberazione, padre della psicologia sociale di liberazione e riferimento principale per la psicologia sociale dell’America Latina, in particolare per la Psicologia di Comunità e la Psicologia politica.
Fu ucciso da un plotone del battaglione Atlacatl delle Forze Armate Governative di El Salvador, sotto il comando del colonnello René Emilio Ponce, il 16 novembre, 1989, insieme ad altri quattro sacerdoti e a due impiegate. Questo efferato delitto ebbe come effetto da una parte l’intensificarsi della lotta del Fronte Nazionale di Liberazione (FNML), dall’altra la comunità internazionale richiese con più forza alle parti contendenti la firma di un accordo di pace, che avvenne nel 1992.
**Rocco Michelangelo Canosa, medico psichiatra, psicoterapeuta.
Ha lavorato nella Clinica Psichiatrica dell’Università di Bari, nei Dipartimenti di Salute Mentale di Trieste, Bari e Matera. In qualità di esperto in salute mentale, per conto del Governo Italiano (MAE) , delle Nazioni Unite e dell’OMS, ha effettuato missioni in Nicaragua, El Salvador, Guatemala, India, Bosnia e Albania.