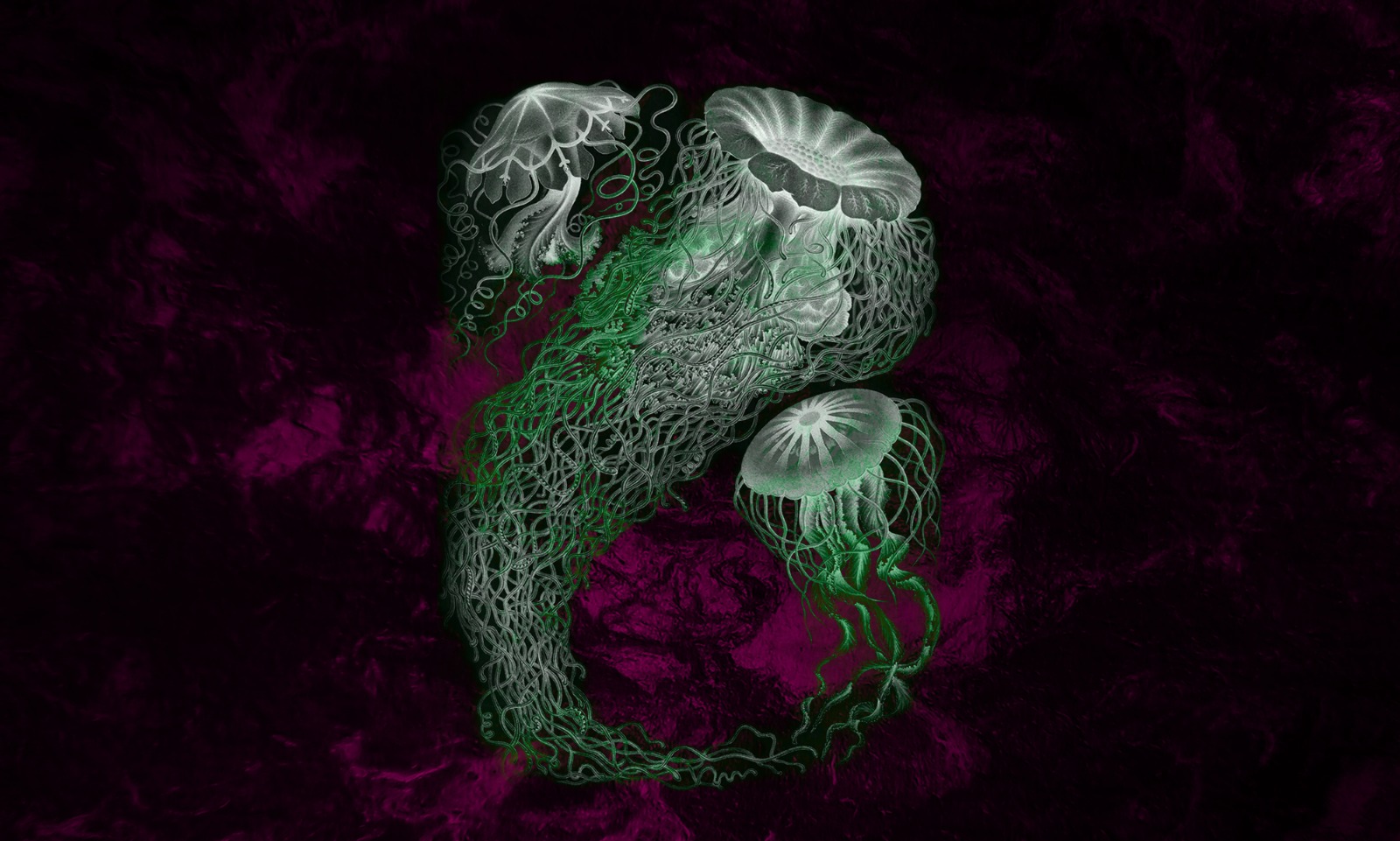di Rocco Canosa

L’operazione di Basaglia è un’operazione utopica. E perciò sarebbe errato considerare la chiusura dei manicomi, sancita dall’intervento a suo modo rivoluzionario della legge 180 del 1978, come il risultato maggiore dell’opera e delle intenzioni di Basaglia. Il cammino che Basaglia voleva avviare era un sommovimento della società e una rivisitazione dei rapporti sociali a partire dalla clinica psichiatrica, proprio quella clinica che a suo tempo era nata per tutelare la cattiva coscienza della società, la quale, per garantire la sua quiete e i rapporti di potere in essa vigenti, non aveva trovato di meglio che incaricare la clinica a fornire le giustificazioni scientifiche che rendessero ovvia e da tutti condivisa la reclusione dei folli entro mura ben cinte. Per rendere il suo servizio, la clinica ridusse la follia a malattia che, per essere curata, deve essere sottratta al mondo in cui essa ha origine che è poi il mondo della vita.
La chiusura dei manicomi non era lo scopo finale dell’operazione basagliana, ma il mezzo attraverso cui la società potesse fare i conti con le figure del disagio che la attraversano quali la miseria, l’indigenza, la tossicodipendenza, l’emarginazione e persino la delinquenza a cui la follia non di rado si imparenta. E come un tempo la clinica aveva messo il suo sapere al servizio di una società che non voleva occuparsi dei suoi disagi, Basaglia tenta l’operazione opposta, l’accettazione da parte della società di quella figura, da sempre inquietante, che è il diverso. Nelle Conferenze brasiliane Basaglia dà due definizioni di follia. La prima: “La follia è diversità, oppure aver paura della diversità”. La seconda: “La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia, invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d’ essere”.
Trattato come uomo, il folle non presenta più una “malattia”, ma una “crisi”, una crisi vitale, esistenziale, sociale, familiare che sfuggiva a qualsiasi “diagnosi” utile solo a cristallizzare una situazione istituzionalizzata. E, scrive Basaglia: “Una cosa è considerare il problema una crisi, e una cosa è considerarlo una diagnosi, perché la diagnosi è un oggetto, la crisi è una soggettività”. E cosa diventa la cura quando i rapporti sono intersoggettivi e non rapporti oggettivanti? La risposta di Basaglia è: “Io cerco di curare una persona, ma non sono certo se la curo o no. E la stessa cosa quando dico di amare una donna. È molto facile dirlo, e talvolta è persino falso, perché l’uomo tende ad un tipo di relazione e la donna a un altro. Quando si crea una relazione d’ amore, questa non è altro che una crisi, una crisi in cui c’è vita se non c’è dominio dell’uomo sulla donna o della donna sull’uomo”.
Basaglia propone di inserire la medicina in un pensiero che tenga conto dell’uomo nella sua globalità per liberarla dalla natura oggettuale del suo rapporto con il paziente.
Il malato e la malattia non possono essere considerati come ‘dati’ oggettivabili della scienza nella misura in cui coinvolgono tutta la personalità del paziente, così come quella del terapeuta nella relazione di cura, e insieme i loro sistemi di credenze e di valori.
In fondo, il pensiero fenomenologico di Husserl, nato come risposta alla crisi delle scienze e alla disumanizzazione in cui era entrata l’Europa, riportava alla ribalta il problema dell’uomo, non come categoria astratta, ma come soggetto-oggetto di una diffusa sofferenza sociale. Questo portava Basaglia ad avvicinare il malato mentale senza i diaframmi impliciti delle rigide tassonomie sintomatologiche delle sindromi, attraverso la comprensione delle sue diverse modalità di esistenza.
In questo modo metteva quindi in crisi la validità della definizione classica di malattia, dei limiti della norma che tale malattia trasgredisce, del concetto di cura, e criticava l’Istituzione Totale in quanto strumento di contenimento e di controllo degli elementi di disturbo sociale.Per Basaglia l’approccio naturalistico-classificatorio del modello medico fa dell’osservazione un momento di definizione e non di comprensione (l’esempio di questo tipo di approccio è dato dalla classificazione delle malattie mentali fatta dallo psichiatra E. Kraeplin).
Pensare ad un catalogo dei sintomi è inutile, vista l’impossibilità di spiegare come e perché si verifica un determinato «fatto anomalo», e non di un «fatto anormale»; in questo il suo punto di vista assomiglia a quello di Georges Canguilhem, che vedeva nel concetto di «anomalia» un pensiero descrittivo-conoscitivo, mentre quello di «anormalità» esprimerebbe un giudizio di valore. Il nodo centrale diviene allora l’analisi del rapporto tra salute e malattia. La netta separazione tra l’una e l’altra è individuata per quel che è: il diretto prodotto dell’ideologia medica.
“Nel momento in cui la salute viene assunta come valore assoluto, la malattia si trova a giocare un ruolo di accidente che viene ad interferire nel normale svolgersi della vita come se la norma non fosse racchiusa tra la vita e la morte. L’ideologia medica, per il suo rifarsi ad un valore astratto e ipotetico qual è la salute come unico valore positivo, agisce da copertura a quella che è l’esperienza fondamentale dell’uomo: il riconoscimento della morte come parte della vita assumendola su di sé come oggetto di una esclusiva competenza. Essa cioè distrugge il malato nel momento in cui lo guarisce defraudandolo del suo rapporto con la propria malattia (quindi col proprio corpo) che viene vissuta come passività e dipendenza. In questo senso il medico diventa responsabile all’insorgere di una relazione reificata tra l’uomo e la propria esperienza inducendo il malato a vivere la malattia come puro accidente oggettivabile della scienza e non come esperienza personale.”
Nello stato relativamente arretrato della nostra società l’ideologia della diversità, dove il positivo si afferma e si conferma sull’esistenza e l’esasperazione degli opposti (salute e malattia, norma e devianza, ragione e follia), fonda il valore e la valorizzazione dei primi attraverso la svalorizzazione del negativo.
Qui si pone la questione centrale della riflessione di Basaglia, centrale sia dal punto di vista epistemologico che pratico, la questione dell’incontro e delle sue implicazioni psicorelazionali.
Non ci può essere cura se non c’è reciprocità, non c’è reciprocità se non c’è riconoscimento (di sé e dell’altro), non c’è riconoscimento possibile se non c’è incontro. Tutto l’approccio terapeutico basagliano può essere definito come tecnica dell’incontro comprensivo.
Il medico, ma possiamo anche dire lo psicologo, l’antropologo, il pedagogo, non può restare estraneo alla situazione di relazione che si crea, poiché «unisce la nostra esistenza a quella del soggetto che ci sta di fronte».
Lo stabilirsi del «rapporto» quindi diviene possibile attraverso la comprensione dell’elemento umano che ci unisce all’altro essere: da ciò deriva che l’esame dell’«incontro» esige un doppio orientamento: da un lato conoscere empiricamente la maniera nella quale «questo» uomo entra in rapporto con il mondo e con gli altri, scoprire, cioè, le «situazioni di fatto», ricavando da esse i progetti e le loro strutture; dall’altro la conoscenza di queste modalità d’incontro dev’essere diretta da una comprensione essenziale dell’esistenza umana.
Il sogno di Basaglia era che la clinica potesse divenire un laboratorio per nuove forme di relazioni sociali, diceva: “la qualita’ delle prestazioni erogate in un Servizio e’ in stretta correlazione con la concezione che dell’uomo si ha in quel Servizio”.
A questo proposito, come movimento antistituzionale, per troppo tempo abbiamo enfatizzato la “diversità” del matto. Se da una parte questo ci ha consentito di difendere la diversità come ricchezza, come valore, dall’altra ha confermato paradossalmente che la persona che soffre psicologicamente è “altro” rispetto ai più, ai cittadini e ai pazienti “normali”.
Questa idea ha investito anche gli operatori psy e i loro servizi, che sono stati visti dal mondo della medicina come “estranei” da se stessa.
Forse abbiamo sottovalutato l’importanza che proprio quel mondo andava attraversato con più pazienza e attenzione, svelando nel contempo i meccanismi opprimenti delle “istituzioni morbide”, molto simili a quelli del manicomio.
Sarebbe giunto il momento, ad esempio, di analizzare i dispositivi umilianti dell’ospedale generale e non limitarsi solo a lamentarci quando i nostri pazienti sono rifiutati dai medici di un reparto.
Non va rivendicato solo il diritto che, in un ospedale, il paziente psichiatrico sia trattato come gli altri malati, ma lavorare affinché tutti gli operatori della medicina siano consapevoli che i loro atti possono essere di riguardo o, al contrario, di mortificazione della sofferenza.
Quando parliamo di “integrazione”, dunque, vogliamo riferirci non tanto all’accettazione caritatevole del “matto”, quanto all’incontro della cultura della tecnica (quella sanitaria in particolare) con la cultura del rispetto, della comprensione, della tolleranza.
Da tempo, ormai, gli scenari della sofferenza psy sono mutati.
Tossicodipendenti, persone neurodivergenti, autistici, minori a rischio, anziani soli, divorziati impongono la loro presenza e la loro drammatica richiesta d’aiuto. Anzi accade spesso che le istituzioni (scuole, tribunali) deleghino ai servizi di salute mentale situazioni che di psichiatrico hanno ben poco e che invece sono gravati di ben altri problemi: sociali, economici, lavorativi.
Ancora una volta ci troviamo di fronte al dilemma: li prendiamo in carico, rischiando la psichiatrizzazione di problematiche sociali o li scarichiamo per “non competenza”?
La nostra storia, la nostra cultura è quella della presa in carico e certamente non li rifiutiamo, ma dobbiamo analizzare in quale circuito assistenziale vengono immessi e quanto possiamo fare affinché la risposta assistenziale sia il meno escludente possibile.
E ciò è praticabile se rimaniamo chiusi nella nostra cittadella di “specialisti della diversità”? E’ possibile se pensiamo che siamo gli unici ad essere “specialisti delle Istituzioni”?
Confrontandoci con la cultura medica, anche quella più tradizionale (vedi i rapporti con i medici ospedalieri) abbiamo conosciuto colleghi che hanno aperto la loro mente alla riflessione sui rischi di istituzionalizzazione in un ospedale generale, geriatri diventati molto attenti per evitare che una RSA divenisse un piccolo manicomio, pediatri che hanno preferito valorizzare il ruolo della “famiglia che cura” e non inviare sbrigativamente il bambino autistico in centri specialistici.
§Abbiamo impiegato molte energie, nei decenni passati, a costruire modelli di servizi di salute mentale di buona qualità. Sicuramente quello del servizio aperto 24 ore sette giorni su sette è vincente. Ma non basta.
Poiché pensiamo che i percorsi di cura non possano esaurirsi all’interno dei servizi di salute mentale, siamo chiamati ad un nuovo impegno culturale e politico.
L’impegno culturale –crediamo- consiste nell’analisi e svelamento dei dispositivi degradanti e di rinnovato controllo sociale delle istituzioni soft e in una continua opera di controinformazione.
Riteniamo che sia giunto il momento di attrezzarci per diffondere informazioni contro i luoghi comuni delle cosiddette “cure per il bene dei pazienti” (anche l’elettroshock era propagandato così), a cominciare dagli effetti devastanti degli psicofarmaci.
Le informazioni critiche, però, dovrebbero riguardare anche le conseguenze deleterie di centri diurni che assomigliano più a ghetti per matti che a luoghi di accoglienza, di case-famiglia che di “famiglia” non hanno neanche l’ombra, di centri di salute mentale che sono ambulatorietti per la “piccola psichiatria”.
In quest’azione forse ci potrebbe servire fare più spesso riferimento alla letteratura e alla bibliografia indipendenti piuttosto che far ricorso a posizioni (sia pure corrette) autoreferenziali.
Insomma, dopo aver costruito oltre trent’anni fa i nuovi servizi, dobbiamo cominciare a smontarli, per evitare di affermare una “ideologia di ricambio”, utile solo a controllare intere masse di uomini e donne, sotto l’orpello della novità.
E l’ideologia di ricambio attuale può essere definita “la salute ad ogni costo” (inclusa la salute mentale): è il “biopotere” come definito da Michel Foucault, una forma di potere della postmodernità che si esercita sulla vita delle persone attraverso dispositivi che orientano e controllano i comportamenti di intere popolazioni, tesi ad evitare la malattia.
La persona con handicap sia fisico che psichico è l’esempio che ci fa ben capire questa concezione. E’ l’espressione tangibile, visibile della nostra fragilità e tutta l’ideologia del salutismo individuale si fonda sul rifiuto della fragilità. Ed ecco che si approntano una tecniche seriali più o meno sofisticate per azzerare l’anormalità.
Anche la psichiatria, benché di nuovo vestita, non si sottrae a questa idea e ha nel suo DNA le pratiche di normalizzazione.
Di questo siamo convinti da tempo, ma dobbiamo ridimensionare l’approccio ideologico, per rilanciare la consapevolezza che la “follia è una condizione umana”.
Il vero delirio è pensare di poterla eliminare.
Il nostro compito è quello di starle accanto, umilmente, anziché combatterla, presuntuosamente.
Forse questo è il nostro attuale impegno “politico”, come possibilità del cambiamento nel senso non tanto dei comportamenti, quanto dei sentimenti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Basaglia F., Conferenze brasiliane, Cortina 2018
Benasayag M., La salute ad ogni costo, Feltrinelli 2009
Canguilhem G., Il normale e il patologico, Einaudi 1996
Foucault M., Nascita della biopolitica, Feltrinelli 2015
Husserl E., Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einaudi 2002
Kraepelin E., Compendio di Psichiatria, Vallardi 1885